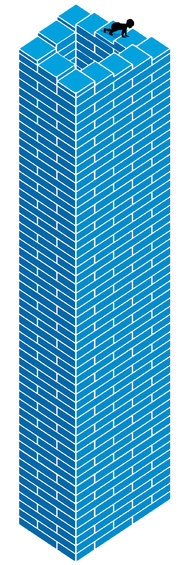E’ ben noto che la disuguaglianza di reddito e di ricchezza nella maggior parte dei paesi ricchi, specialmente negli Stati Uniti, ha vissuto un’impennata nei decenni recenti, tragicamente, aggravata ancor più dopo la Grande Recessione. Ma che dire del resto del mondo? Il divario tra i paesi si va riducendo e potenze economiche in ascesa, come la Cina e l’India, hanno sollevato dalla povertà centinaia di milioni di persone? E all’interno dei paesi poveri e di quelli a medio reddito la disuguaglianza va peggiorando o migliorando? Ci stiamo dirigendo verso un mondo più equo o verso uno più ingiusto?
Si tratta di domande complesse e una nuova ricerca dell’economista della Banca Mondiale Branko Milanovic, assieme ad altri studiosi, indica la via ad alcune risposte.
A partire dal diciottesimo secolo la rivoluzione industriale ha prodotto una gigantesca ricchezza in Europa e nell’America del Nord. Naturalmente le disuguaglianze all’interno di tali paesi erano spaventose – si pensi alle fabbriche tessili di Liverpool e Manchester, in Inghilterra, negli anni ’20 del 1800 e ai caseggiati della Lower East Side di Manhattan e della South Side di Chicago intorno al 1890 – ma il divario tra i ricchi e il resto, come fenomeno globale, si è allargato ancor di più fino alla seconda guerra mondiale. Oggi la disuguaglianza tra i paesi è molto maggiore che la disuguaglianza all’interno dei paesi.
Ma circa dalla caduta del comunismo nei tardi anni ’80, la globalizzazione economica è accelerata e il divario tra nazioni ha cominciato a ridursi. Il periodo dal 1988 al 2008 “potrebbe aver visto il primo declino della disuguaglianza globale tra i cittadini del mondo dopo la Rivoluzione Industriale” ha scritto in un documento pubblicato a novembre dell’anno scorso Milanovic, nato nell’ex Jugoslavia e autore di “The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality” [Chi ha e chi non ha: una storia breve e peculiare della disuguaglianza globale]. Mentre il divario tra alcune regioni si è marcatamente ridotto – cioè tra l’Asia e le economie avanzate dell’Occidente – permangono grandi differenze. I redditi medi globali, per paese, si sono avvicinati negli ultimi decenni, particolarmente per la forza della Cina e dell’India. Ma l’uguaglianza complessiva, a livello dell’intera umanità e guardando ai singoli, è migliorata molto poco. (Il coefficiente Gini, una misura della disuguaglianza, è migliorato di soli 1,4 punti dal 2002 al 2008).
Così mentre nazioni dell’ Asia, del Medio Oriente e dell’ America Latina, nel complesso, si starebbero mettendo al passo con l’Occidente, i poveri sono lasciati dappertutto indietro, anche in realtà come la Cina, dove hanno in qualche misura beneficiato del tenore di vita in ascesa.
Dal 1988 al 2008, ha scoperto Milanovic, l’un per cento al vertice mondiale ha visto aumentare i propri redditi del 60 per cento, mentre quelli nella fascia del 5% più in basso non hanno visto variazioni del proprio reddito. E anche se i redditi medi sono molto cresciuti nei decenni recenti, ci sono ancora enormi squilibri: l’otto per cento dell’umanità incamera il cinquanta per cento del reddito globale; l’un per cento al vertice, da solo, incamera il quindici per cento. Gli incrementi di reddito sono stati maggiori presso l’élite globale – dirigenti finanziari e industriali dei paesi ricchi – e presso le grandi “classi medie emergenti” di Cina, India, Indonesia e Brasile. Chi ha perso? Gli africani, alcuni paesi latinoamericani e i popoli dell’Europa Orientale ex comunista e dell’ex Unione Sovietica, ha scoperto Milanovic.
Gli Stati Uniti offrono al mondo un esempio particolarmente fosco. E poiché, per così tanti versi, gli Stati Uniti “guidano il mondo”, se altri seguiranno l’esempio statunitense, le cose non si presentano bene per il futuro.
Da un lato l’ampliamento della disuguaglianza di reddito e di ricchezza negli Stati Uniti fa parte di una tendenza osservata in tutto il mondo occidentale. Uno studio del 2011 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rilevato che la disuguaglianza di reddito ha iniziato la sua ascesa nei tardi anni ’70 e nei primi anni ’80 negli Stati Uniti e in Gran Bretagna (e anche in Israele). La tendenza si è fatta più diffusa a partire dai tardi anni ’80. Nell’ultimo decennio la disuguaglianza di reddito si è accresciuta anche in paesi tradizionalmente ugualitari, come Germania, Svezia e Danimarca. Con poche eccezioni – Francia, Giappone, Spagna – il 10% al vertice dei percettori nelle economie più avanzate ha fatto un balzo in avanti, mentre il 10% nella fascia più bassa è andato ancor più indietro.
Ma la tendenza non è stata né universale né inevitabile. Nel corso degli stessi anni paesi come Cile, Messico, Grecia, Turchia e Ungheria sono riusciti a ridurre significativamente differenze di reddito anche molto elevate, suggerendo che la disuguaglianza è un prodotto di forze politiche e non semplicemente macroeconomiche. Non è vero che la disuguaglianza è un sottoprodotto inevitabile della globalizzazione, del libero movimento del lavoro, del capitale, delle merci e dei servizi e di cambiamenti tecnologici che favoriscono dipendenti più specializzati e con un’istruzione superiore.
Tra le economie avanzate, gli Stati Uniti hanno alcuni delle differenze di reddito e di opportunità peggiori, con conseguenze macroeconomiche devastanti. Il prodotto interno lordo degli Studi Uniti si è più che quadruplicato negli ultimi quarant’anni e quasi raddoppiato negli ultimi venticinque ma, com’è ben noto, i vantaggi sono andati al vertice e sempre più al segmento più elevato del vertice.
L’anno scorso l’un per cento degli statunitensi ha incamerato il 22 per cento del reddito nazionale; lo 0,1 per cento, l’11 per cento. Il 99% di tutti gli incrementi di reddito dal 2009 è andato all’un per cento al vertice. Dati di censimento recentemente diffusi mostrano che il reddito mediano negli Stati Uniti non si è mosso per quasi un quarto di secolo. Il maschio tipico statunitense guadagna meno di 45 anni fa (al netto dell’inflazione); i maschi diplomati alle superiori ma privi di una laurea quadriennale guadagnano quasi il 40 per cento in mendo rispetto a quattro decenni fa.
La disuguaglianza statunitense ha cominciato la sua ascesa trent’anni fa, assieme a riduzioni delle tasse ai ricchi e all’alleggerimento delle regole del settore finanziario. Non è una coincidenza. E’ peggiorata con la riduzione degli investimenti in infrastrutture, sistemi di istruzione e di assistenza sanitaria e di reti di sicurezza sociale. La disuguaglianza crescente si rafforza corrodendo il nostro sistema politico e il nostro governo democratico.
E l’Europa sembra sin troppo ansiosa di seguire il cattivo esempio degli Stati Uniti. L’abbraccio dell’austerità, dalla Gran Bretagna alla Germania, sta portando a un’elevata disoccupazione, a una caduta dei salari e a un’accresciuta disuguaglianza. Dirigenti come Angela Merkel, l’appena rieletta cancelliere della Germania, e Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, sostengono i problemi dell’Europa sono la conseguenza di una spesa assistenziale dilatata. Ma quel modo di pensare ha soltanto portato l’Europa nella recessione (e persino nella depressione). Che si possa aver toccato il fondo – che la recessione possa essere “ufficialmente” terminata – è di scarso conforto per i 27 milioni di senza lavoro nella UE. Su entrambe le sponde dell’Atlantico i fanatici dell’austerità proseguono la loro marcia: queste sono pillole amare che dobbiamo buttar giù per conseguire la prosperità. Ma la prosperità per chi?
L’eccesso di finanziarizzazione – che contribuisce a spiegare il dubbio status della Gran Bretagna come secondo paese più disuguale, dopo gli Stati Uniti, tra le economie avanzate del mondo – contribuisce anche a spiegare l’impennata della disuguaglianza. In molti paesi, un’amministrazione industriale debole e l’erosione della coesione sociale hanno condotto a crescenti divari tra le remunerazioni dell’alta dirigenza e quelli dei lavoratori comuni, che ancora non si avvicinano al livello di 500 a 1 delle maggiori imprese statunitensi (secondo la stima dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro) ma comunque maggiori dei livelli pre-recessione. (Il Giappone, che ha tagliato le remunerazioni dei dirigenti, è un’eccezione rimarchevole). Le innovazioni statunitensi nella ricerca della rendita – arricchirsi senza ingrandire la torta dell’economia, bensì manipolando il sistema per impossessarsi di una fetta più grande – sono diventate globali.
La globalizzazione asimmetrica ha anche incassato il proprio tributo in tutto il globo. I capitali mobili hanno preteso che i lavoratori facessero concessioni salariali e che i governi facessero concessioni fiscali. La conseguenza è una corsa verso il fondo. I salari e le condizioni di lavoro sono minacciati. Imprese all’avanguardia, come la Apple, la cui operatività si affida a enormi progressi della scienza e della tecnologia, molti dei quali finanziati dal governo, hanno dimostrato anche una grande destrezza nell’eludere le tasse. Vogliono prendere, ma non restituire.
La disuguaglianza e la povertà tra i bambini sono una vergogna morale speciale. Sfidano le affermazioni della destra che la povertà è una conseguenza di pigrizia e di scarse scelte; i bambini non possono scegliersi in genitori. Negli Stati Uniti quasi un bambino su quattro vive in povertà; in Spagna e in Grecia, quasi uno su sei; in Australia, Gran Bretagna e Canada più di uno su dieci. Nulla di tutto questo è inevitabile. Alcuni paesi hanno fatto la scelta di creare economie più eque: la Corea del Sud, dove mezzo secolo fa solo un cittadino su dieci arrivava alla laurea, ha oggi uno dei tassi più elevati di completamento degli studi universitari.
Per questi motivi ci vedo entrare in un modo diviso non solo tra chi ha e chi non ha, ma anche tra i Paesi che non fanno nulla al riguardo e quelli che fanno qualcosa. Alcuni Paesi avranno successo nel creare una prosperità condivisa, l’unico genere di prosperità che ritengo davvero sostenibile. Altri lasceranno che la disuguaglianza finisca fuori controllo. In queste società divise, i ricchi troveranno riparto in comunità chiuse, quasi completamente separati dai poveri, le cui vite risulteranno loro incomprensibili, e viceversa. Ho visitato società che sembrano aver scelto questa via. Non sono posti in cui la maggior parte di noi vorrebbe vivere, che si tratti delle loro enclave arroccate o delle loro disperate baraccopoli.
Traduzione di Giuseppe Volpe per Z Net Italy
Fonte: New York Times
30 ottobre 2013